SECONDO CH’ELLI VIDE COGLI OCCHI SUOI
«Partendosi di là e andando tre giornate verso levante, l’uomo si trova a Diomira, città con sessanta cupole d’argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d’oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: uh!, viene da invidiare quelli che ora pensano d’aver già vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici»1.
Ritorno così spesso a Le città invisibili di Calvino, che interi passi risuonano nella mia testa come un mantra, quasi ossessivamente, apparendomi, ora come sogni, altre volte come incubi. Sono visioni che vengono a visitarmi, in una sorta di veglia-onirica, in cui il piano della realtà e quello della narrazione si sovrappongono in strati traslucidi, determinando vari livelli di profondità e differenti volumi. In essi il ‘percepito’ e il ‘filtrato dal testo’ si fondono, rendendone talora indefinibile il confine netto.
Perché, mi domando, continuo instancabilmente a riprendere quei passi, esattamente come mi capita di riascoltare infinite volte le stesse musiche?
Una risposta immediata nasce dal prendere coscienza della fascinazione esercitata su di me da opere che inseguono la struttura stessa della narrazione come ‘soggetto’ dell’opera d’arte, espressa però attraverso le sue manifestazioni meno evidenti, a tal punto assimilate e perfezionate dall’autore da apparire semplici e lineari, quasi fossero frutto della natura o della necessità. Un altro motivo sta nella musicalità di ciò che leggo, che apprezzo meglio se lo faccio ad alta voce. È uno sviluppo di parole in frasi liriche, dotate di punteggiatura e cura, cesellate in particolari appena accennati, ma che alludono a interi cosmi di significato. Ci sono pensieri che suonano come melodie, armonizzate in tonalità diverse e modulanti, con coloriture meste, gioiose, cupe, malinconiche, sensuali, ironiche.
Se vado più in profondità, però, è la relazione tra testo e immagini ad avvincermi in modo speciale. Il viaggio fantastico che la parola c’invita a intraprendere è vero per tutti i romanzi2, ma Le città invisibili parlano alla mia immaginazione più di altri e lo fanno con un linguaggio che evoca un mondo di cui essa, in un certo senso, s’è innamorata e lì vuol tornare ancora, e ancora, per ritrovarne i colori, la luce, i profumi, le sensazioni e gli stati d’animo. Tuttavia, quando vi giunge nuovamente, ecco altri particolari, territori sfuggiti, nelle letture precedenti, all’attenzione. Nuovi spazi si aprono e scopro altri luoghi, che nessun “open world”3 riuscirebbe a eguagliare:
«Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l’imperatore dei tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore»4.
Calvino apre il romanzo con un artificio. È Marco Polo, il giovane esploratore veneziano, che riferisce all’imperatore delle città incontrate viaggiando per l’impero, un territorio tanto esteso da sembrare infinito, la cui immensità condanna il sovrano a conoscerne la realtà solo attraverso i racconti dei suoi emissari. Ci si trova in un racconto a propria volta raccontato. Dal Libro de’ sette savi, al Decameron, a I racconti di Canterbury, alla Pastorale americana, fino a Hyperion, la ‘cornice narrativa’ è uno strumento perfetto per esprimere la propria visione sul contenuto, oppure per prendere distanza da esso. In Calvino, tuttavia, la cornice assume una caratteristica propria, che si coglie subito nella parte restante del brano introduttivo:
«Nella vita degli imperatori c’è un momento, che segue all’orgoglio per l’ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli; un senso come di vuoto che ci prende una sera con l’odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri; una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi, arrotola uno sull’altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta, e scrosta la ceralacca dei sigilli di re mai sentiti nominare che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi, pelli conciate e gusci di testuggine: è il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana d’un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti»5.
Nelle sue pagine, Calvino ci fa visitare un labirinto di metropoli nascoste, borghi celati, urbanizzazioni segrete, ‘terreni vaghi’, ma, mentre in altre opere la differenza tra ciò che è dentro la cornice e ciò che rimane fuori risulta chiaro – e, analogamente, ha senso domandarsi cosa sia reale e cosa non lo sia –, nelle Città invisibili si schiude uno ‘spazio altro’, nel quale è più difficile discernere tra il reale e l’immaginato, fino a suggerire l’insensatezza di una soluzione dirimente dal punto di vista ontologico, tra il dentro e il fuori dalla cornice6.
VISIBILITÀ
La prospettiva di senso, emergente dai racconti di Polo, m’attrae. Noto che mi spinge inevitabilmente a interrogarmi sull’idea che Calvino aveva della funzione immaginativa.
Nelle sue Lezioni americane, Calvino si sofferma sul verso di Dante, presente nel XVII canto del Purgatorio: “Poi piovve dentro a l’alta fantasia”. Partendo da questa affermazione, analizza il funzionamento dell’immaginazione nella Divina Commedia: «Le immagini che Dante contempla durante il suo viaggio ultraterreno rappresentano esempi classici e biblici della punizione nei confronti dell’ira e si presentano in diverse forme, dalle raffigurazioni, sotto forma di bassorilievi, a immagini puramente mentali. Dante definisce “l’alta fantasia” come la parte più elevata dell’immaginazione, distinta dall’immaginazione corporea, che si manifesta nei sogni, con la loro confusione. Secondo Dante e San Tommaso d’Aquino, c’è una sorgente luminosa, che si trova in cielo e che trasmette immagini ideali – formate o secondo la logica intrinseca del mondo immaginario o secondo il volere di Dio –. La posizione dell’immaginazione nella Divina Commedia è centrale. Il poeta deve immaginare visualmente sia ciò che il suo personaggio vede, sia ciò che crede di vedere – che sta sognando, che ricorda, che vede rappresentato o che gli viene raccontato –, In maniera simile deve creare il contenuto visuale delle metafore utilizzate, per facilitarne l’evocazione. La parte visuale della sua fantasia precede o è contemporanea all’immaginazione verbale.
Il processo immaginativo può prendere le mosse sia dalla parola, sia dall’immagine visiva. Il primo caso si verifica quando leggiamo un romanzo o un reportage e siamo portati a vedere la scena come se si stesse svolgendo davanti ai nostri occhi. Il secondo caso è tipico dei film. L’immagine che vediamo sullo schermo è passata da un testo scritto, poi è vista mentalmente dal regista, ricostruita nella sua fisicità sul set, per essere definitivamente fissata nei fotogrammi.
Il “cinema mentale” dell’immaginazione ha un compito altrettanto importante quanto quello in cui si realizzano effettivamente le sequenze che vengono registrate dalla camera e successivamente montate. Questo cinema non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vista interiore»7.
Calvino, non solo espone come intenda il ruolo dell’immaginazione nell’arte, riconoscendone la capacità di generare mondi immaginari, che trovano la loro radice d’essere nella nostra mente, ma si concentra sul processo immaginativo, sul flusso d’immagini che passano da una mente all’altra, formando un reticolo di significati che si arricchisce progressivamente di dettagli, di nodi come nuclei immaginativi, costruendo una sorta di mappa intersoggettiva in continua evoluzione ed espansione.
Forse per questo motivo e sicuramente per altri che ignoro, Le città invisibili, esempio paradigmatico di “cinema mentale” sempre in funzione in tutti noi8, sono state fonte d’ispirazione per molti artisti e, credo, lo saranno per molto tempo ancora.
VISIBILIA EX INVISIBILIBUS
Si apre dunque un nuovo sentiero, che conduce agli artisti che hanno voluto ‘dare corpo’ alle città descritte da Calvino. Lo imbocco senza ambizione d’ordine, sistematicità o completezza –sono tantissimi gli artisti che si sono cimentati nell’impresa di raffigurare il romanzo –, né tantomeno con la presunzione di offrirne un parere esperto. Semmai, sono mosso dal desiderio di esplorare Le città invisibili – tramite un itinerario soggettivo, facendo riferimento al mio gusto personale, per mezzo di suggestioni, più che di affermazioni –, così come sono state immaginate da altre persone, che contrariamente a me, hanno avuto capacità e talento per ‘farle essere’ nell’universo materiale, quello fatto di cornici di legno, smalto e oro, di acquerelli, acrilici e a olio, di tele che, se guardi dietro, riesci forse a trovare il timbro del produttore, l’etichetta della casa d’aste o un articolo di giornale, appiccicato con lo scotch, che racconta la storia del pittore.
La prima rappresentazione su cui vorrei soffermassimo lo sguardo è quella della città di Diomira di Karina Puente.

Subito la scorgo per differenza. È dissimile dall’immagine che ho in testa. Le sessanta cupole d’argento hanno un ruolo fondamentale nel quadro dell’artista peruviana. Sembrano oggetti sospesi, monadi che galleggiano, ordinate, in un cielo stellato. Trovo – o mi sembra di trovare – altri particolari minuziosi, anche se il predominio della serie è pressoché incontrastato. Nel mio ‘film mentale’, invece, c’è il colore, l’atmosfera delle lampade multicolori sulle porte delle friggitorie e la sensazione nostalgica del crepuscolo settembrino, vissuto tante volte con gioia, nei ricordi delle amicizie estive appena lasciate. Viene da invidiare me stesso per quelle volte. Riflettendo su questo divario, guardo al testo come a un cesto ricolmo di ‘materiale immaginativo’, che il lettore – in questo caso la Puente – combina in un costrutto unitario, in grado di connettersi a un’emozione o a un ambiente emotivamente caratterizzato. L’attenzione di Karina Puente, architetto, è centrata sulla dimensione costruttiva, sulle configurazioni, sulla ricorsività delle forme. Sembra che anche la decorazione giochi una parte essenziale del suo risultato artistico.
In Valdrada, lo specchio è protagonista: «Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive d’un lago con case tutte verande una sopra l’altra e vie alte che affacciano sull’acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore vede arrivando due città: una diritta sopra il lago e una riflessa capovolta»9. È l’elemento costruttivo, la forma, a diventare soggetto del quadro. La città, a prima vista, si rispecchia nel lago, ma osservando meglio si coglie l’eleganza della soluzione. Le due immagini, che appaiono speculari, in realtà non lo sono: «Le due città gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico: a ogni viso e gesto rispondono dallo specchio un viso o gesto inverso punto per punto. Le due Valdrade vivono l’una per l’altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si amano»10.

Karina Puente trova la sua via per realizzare ciò che Francesca Serra definisce «una città dedita a una sola cosa, che sottostà a una sola regola, che conosce un solo modo di essere. Il procedimento narrativo è noto. Si costruisce una situazione perfettamente blindata, per il gusto di mandarla all’aria con qualche evento o arrivo inatteso; o comunque ricavarne qualche morale sulle perversioni di un assetto delle cose così totalitario, sulle incrinature di un sistema così assolutistico. […] Si può dire che Le città invisibili nascano dall’unione di questi due elementi: da una parte l’antico espediente della città univoca, dall’altra una passione, non meno radicata, per la veduta d’insieme di una città»11.
Nondimeno, la resa del rapporto tra testo e immagine non si gioca solo attraverso la scelta dell’unificazione e del ribaltamento, forse perché in Calvino stesso la relazione tra ciò che è scritto e ciò che s’immagina è intenzionalmente multiforme. Questa caratteristica può condurre il pittore a esiti molto distanti da quelli mostrati sopra. Nella composizione di Pino Procopio – è ancora un’immagine per Diomira –, sebbene Calvino non sia stato prodigo d’indicazioni cromatiche, l’artista sceglie di attribuire proprio al colore una posizione comunicativa precipua. Il colore c’è, anche se non viene citato, ed è veicolo d’emozione. Procopio, pur rimanendo fedele allo scritto e alla ricchezza dei particolari – c’è il viaggiatore, ci sono le cupole d’argento, le statue, c’è il gallo, la donna che sta sopra la terrazza, le lampade che colorano la scena, insieme al rosso fiammeggiante sole serotino –, non è didascalico. Al contrario, offre allo spettatore un punto di vista prospettico, personale e, allo stesso tempo, coerente con la poetica di Calvino: «Dipingo accadimenti di vita quotidiana, rendendoli surreali, con figure fantastiche e deformate, come riflesse da specchi convessi»12. Eccoci dinanzi alla scena di un enorme viaggiatore baffuto che cavalca un elefante arancione, il quale è diretto verso la città, camminando sulle sue zampette nere. Non sembra quindi un caso che l’elefante sia presente, abitando sia dentro, sia fuori dalla cornice dei singoli racconti.

Le descrizioni calviniane, peraltro, sembrano avere la straordinaria proprietà di trasformarsi in ‘simbionti’ dei vissuti, delle emozioni e dei ricordi del lettore. Colleen Corradi Brannigan descrive con queste parole il suo incontro con il romanzo: «Il mio primo approccio alle “Città invisibili” è stato di superficiale indifferenza. Non erano altro che parte di un programma universitario da realizzare; rimasero sopite nella mia mente per anni. Poi, un giorno, a New York, mentre lavoravo a incisioni di castelli inglesi che conoscevo bene, Eudossia ha preso forma. È così che le polverose città del passato hanno preso vita e hanno posto le basi dei mondi immaginari che desideravo creare a partire dai disegni “inglesi”. Ora, ogni volta che la mia mente rievoca le strade delle città descritte da Calvino, traggo nuove ispirazioni da parole che non avevo notato prima o da significati che si aprono a nuove interpretazioni in una scoperta che non ha mai fine13».
Le città di Calvino si depositano sulle forme della memoria e forniscono stimoli per rappresentare una città incurvata su se stessa, tutta intenta a suscitare desideri per poi reprimerli. Basta un solo elemento, l’arco, che ricorre molte volte, per esprimere unitariamente la caratteristica circolare e alienante della città di Anastasia:
«Di capo a tre giornate, andando verso mezzodí, l’uomo s’incontra ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora enumerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata onice crisopazio e altre varietà di calcedonio; lodare la carne del fagiano dorato che qui si cucina sulla fiamma di legno di ciliegio stagionato e si cosparge con molto origano; dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca d’un giardino e che talvolta invitano – si racconta – il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell’acqua. Ma con queste notizie non ti direi la vera essenza della città: perché mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a soffocarli, a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte, e poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno ora benigno, ha Anastasia, città ingannatrice: se per otto ore al giorno tu lavori come tagliatore d’agate onici crisopazi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal desiderio la sua forma, e credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei che lo schiavo»14.
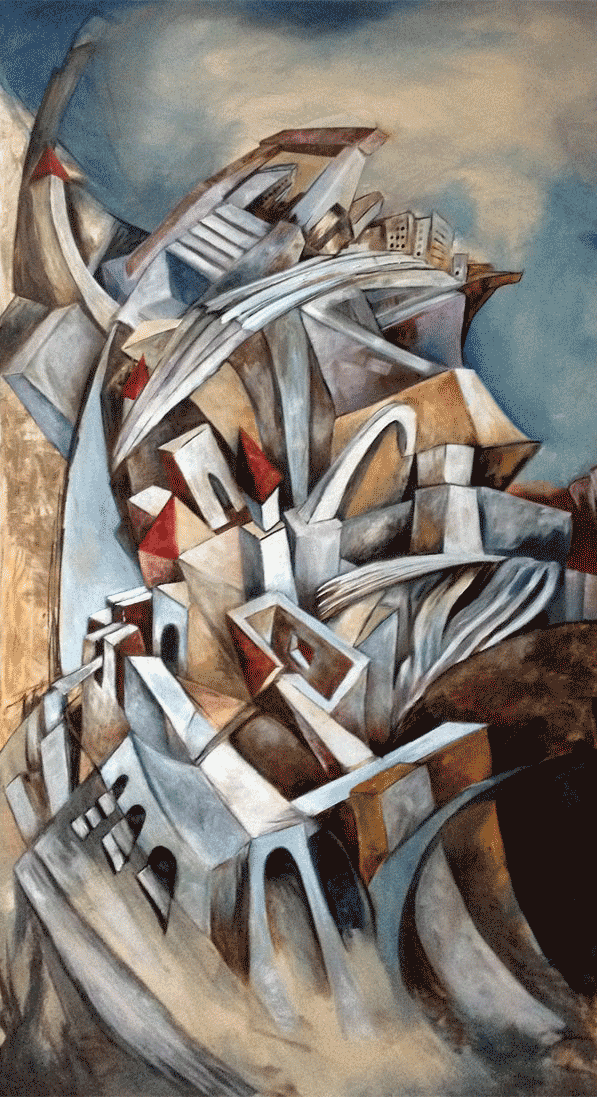
Anche Colleen Corradi Brannigan valorizza il gioco dell’antinomia tra due immagini coesistenti in un’unica città. Le colate e i colori cupi trasmettono una sensazione di angoscia pervasiva. Costruzioni scure, in primo piano, appaiono decadenti e ormai in rovina, mentre, sullo sfondo, in una piccola porzione di cielo chiaro, si staglia lo skyline della stessa Olivia, città idealizzata:
«Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un rapporto. Se ti descrivo Olivia, città ricca di prodotti e guadagni, per significare la sua prosperità non ho altro mezzo che parlare di palazzi di filigrana con cuscini frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata d’un patio una girandola di zampilli innaffia un prato dove un pavone bianco fa la ruota. Ma da questo discorso tu subito comprendi come Olivia è avvolta in una nuvola di fuliggine e d’unto che s’attacca alle pareti delle case; che nella ressa delle vie i rimorchi in manovra schiacciano i pedoni contro i muri. […] Questo forse non sai: che per dire d’Olivia non potrai tenere altro discorso. Se ci fosse un’Olivia davvero di bifore e pavoni, di sellai e tessitori di tappeti e canoe e estuari, sarebbe un misero buco nero di mosche, e per descrivertelo dovrei fare ricorso alle metafore della fuliggine, dello stridere di ruote, dei gesti ripetuti, dei sarcasmi. La menzogna non è nel discorso, è nelle cose»15.

Un’attenzione speciale merita, a mio parere, il lavoro di Pedro Cano. Prescindendo dall’indubbio fascino delle sue creazioni – qualità che apprezzo anche nelle realizzazioni di molti altri artisti, che purtroppo mi è impossibile mostrare, anche solo per cenni –, l’interesse è motivato da due aspetti che collegano direttamente Cano con Le città invisibili. Il primo è di carattere biografico, perché Cano conobbe Calvino di persona: «L’idea del lavoro su Le città invisibili risale a diversi anni indietro, quando la vedova di Calvino regalò all’artista una prima edizione del volume raccomandandone l’accurata lettura. Calvino, infatti, aveva più volte rilevato la propria affinità con l’opera di Cano. L’episodio è degno di nota, poiché la signora Singer, in più occasioni, si era opposta all’idea che Le città venissero illustrate: a suo dire, esse dovevano restare, appunto, invisibili»16. Il secondo si riferisce alla genesi dei lavori di Cano: «Per anni nei miei viaggi ho portato con me questo piccolo libro (Le Città Invisibili di Calvino) e cominciai a fare schizzi negli spazi vuoti che piano piano mi posizionavano in questa geografia di posti inediti ma che mi ricordavano tanti altri posti vissuti nel mio vagabondare per il mondo e che avevo cercato di catturare nei miei taccuini di viaggio. […] Tre anni fa decisi di fare di tutto quel groviglio di segni qualcosa di più preciso e cominciò a delinearsi l’idea che ho scelto per questo lavoro: una specie di taccuino, dove l’immagine non è il risultato di un dialogo con un luogo, ma viene suggerita dalla descrizione di un’altra persona, in questo caso attraverso la parola di Italo Calvino […]. Percorrere questi luoghi per mano di Calvino e dargli colore e forma [il corsivo è mio] è stata una delle avventure più intense della mia vita. Ho usato cinquantacinque fogli di carta fatta a mano, e come unica fonte di colore, l’acquerello. Le parole di Cano suonano quasi identiche a quelle di Calvino: “Così mi sono portato dietro questo libro delle città negli ultimi anni, scrivendo saltuariamente, un pezzetto per volta, passando attraverso fasi diverse”»17.

Spesso in Cano la distanza tra spettatore e oggetto cambia rispetto alle rappresentazioni dei pittori che abbiamo incontrato fin qui. Egli si ‘avvicina’ molto di più o usa un oculare in grado di mettere a fuoco i particolari. Ogni acquerello appare come una miniatura che racchiude l’essenza della città. Sono sorprendenti gli effetti di luce e ombra che, da un lato donano profondità alle immagini, dall’altro riescono a evocare un senso di mistero e stupore, componendo l’antitesi, che incontro in ogni pagina di Calvino, tra mirabilia e quotidiano, tra esotico e domestico. Perciò Tamara è stilizzata in segni: «L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose: la tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo di guardia, la stadera l’erbivendola. Statue e scudi rappresentano leoni delfini torri stelle: segno che qualcosa – chissà cosa – ha per segno un leone o delfino o torre o stella»18.

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI
Volgendoci indietro e ripensando a questa brevissima passeggiata nell’impero del Kan, può darsi nasca in noi il dubbio d’essere rimasti vittime dell’incantesimo di Calvino e in egual misura, della malia degli artisti che hanno cercato di dare forma tangibile a Le città invisibili. Potremmo esserci mossi in uno spazio che non esiste, in un gioco infinito di specchi, all’interno di cornici concentriche in cui tutto si può immaginare o ricostruire a piacimento, come in un inesauribile gioco combinatorio, privo di regole e fatalmente solitario:
«Kublai Kan s’era accorto che le città di Marco Polo s’assomigliavano, come se il passaggio dall’una all’altra non implicasse un viaggio ma uno scambio d’elementi. Adesso, da ogni città che Marco gli descriveva, la mente del Gran Kan partiva per suo conto, e smontata la città pezzo per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli.
Marco intanto continuava a riferire del suo viaggio, ma l’imperatore non lo stava più a sentire, lo interrompeva:
– D’ora in avanti sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Comincerò a chiederti d’una città a scale, esposta a scirocco, su un golfo a mezza luna. Ora dirò qualcuna delle meraviglie che contiene: una vasca di vetro alta come un duomo per seguire il nuoto e il volo dei pesci–rondine e trarne auspici; una palma che con le foglie al vento suona l’arpa; una piazza con intorno una tavola di marmo a ferro di cavallo, con la tovaglia pure in marmo, imbandita con cibi e bevande tutti in marmo»19.
L’imperatore, inebriato dalla purezza della forma e dall’euforia del potere, che gli consentono di assemblare, secondo inediti e arbitrari criteri, gli elementi derivanti da ciò che immagina, deraglia dai binari dell’oggetto per rifugiarsi in un mondo ideale, chiedendo alla realtà d’adeguarsi ad esso.
Tuttavia, Marco lo richiama alla presenza:
«– Sire, eri distratto. Di questa città appunto ti stavo raccontando quando m’hai interrotto.
– La conosci? Dov’è? Qual è il suo nome?
– Non ha nome né luogo. Ti ripeto la ragione per cui la descrivevo: dal numero delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza un filo che li connetta, senza una regola interna, una prospettiva, un discorso. È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra.
– Io non ho desideri né paure, – dichiarò il Kan, – e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso.
– Anche le città credono di essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.
– O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della Sfinge»20.
Ciò che Calvino sottintende non consiste nella scelta risolutiva tra l’oggetto e la sua rappresentazione. Sembra invece invitare il lettore a esercitare le proprie capacità di dimorare in uno spazio intermedio, sospeso tra le due dimensioni, dotato di una propria specifica posizione d’essere e visitabile attraverso la narrazione, ma anche nella rappresentazione di ciò che s’immagina, a partire dalla narrazione stessa – come ho cercato di sostenere, limitandomi a evidenziarne qualche traccia –.
Certo non è facile abitare questo spazio intermedio. Mentre cerchiamo di formare una siffatta abilità, lo sconforto ci potrebbe assalire e avviluppare con i suoi tentacoli glutinosi:
«Già il Gran Kan stava sfogliando nel suo atlante le carte della città che minacciano negli incubi e nelle maledizioni: Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World.
Dice: – Tutto è inutile, se l’ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.
E Polo: – L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio»21.
NOTE
1I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano, 2004, p. 7
2Si potrebbe anche opinare che Le città Invisibili sia un vero e proprio ‘romanzo’ e, soprattutto, un romanzo d’avventura.
3Un open world è un ambiente virtuale in cui il giocatore è libero di affrontare gli obiettivi senza vincoli dettati da una sequenza di eventi che governa la vicenda o da una struttura prestabilita. In altre parole, l’utente ha la possibilità di esplorare l’ambiente di gioco a proprio piacimento e di decidere autonomamente il percorso da seguire.
4Op. cit., p. 5.
5Ivi.
6Illuminante, dal punto di vista filosofico, è AA. VV., Il filosofo e le città, a cura di A. Ichino e M. Perego, CUEM, 2006.
7Parafrasi da I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, 2002, p. 91 e sgg.
8Ivi.
9I. Calvino, Le città invisibili, op. cit., p. 7.
10Ivi.
11F. Serra, Calvino, Salerno editrice, Roma, 2006, pp. 322-323.
12www.pinoprocopio.it
13www.cittainvisibili.com
14I. Calvino, Le città invisibili, op. cit., p. 12.
15Ivi, pp. 61 e 62.
16A. Kreisberg, “Le città invisibili” nell’immaginario di Italo Calvino e nelle immagini di Pedro Cano, in “Italies, La plume et le crayon. Calvino, l’écriture, le dessin, l’image”, 16/2012, pp. 439-458.
17Ivi.
18I. Calvino, Le città invisibili, op. cit., p. 13.
19Ivi, pp. 43.
20Ivi, pp. 43 e 44.
21Ivi, pp. 163 e 164.




